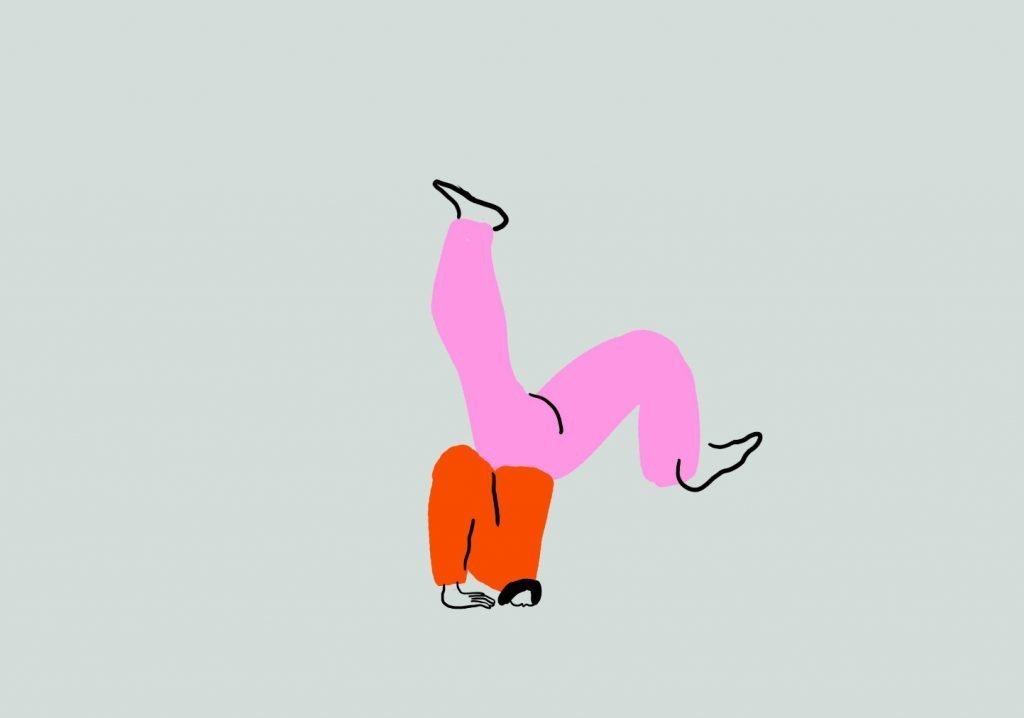Perché tanti corsi di formazione e perché tutti – almeno così sembra oggi – vogliono diventare insegnanti di yoga? Lo yoga è ormai “quella cosa che tutti vogliono insegnare e ben pochi praticare”?
Leggiasana
Yogasana 8: lo Yoga del Cuore
La connessione mente-cuore-corpo tra Yoga, neurofisiologia, anatomia e Medicina Tradizionale Cinese. Seminario di formazione per insegnanti e praticanti. Febbraio-aprile 2024. Perché nello Yoga dovremmo sostituire la parola ‘mente’ con il termine ‘mente-cuore‘? Quali sono le relazioni tra il cuore, la respirazione e la muscolatura profonda, così sensibili alle dimensioni emotiva e intuitiva? Qual è il […]
LeggiYogasana 8: Mindfulness/Heartfulness
Esplorare le connessioni mente-cuore-corpo, tra Yoga posturale moderno, Yoga tantrico delle origini, neurofisiologia e anatomia, Medicina Tradizionale Cinese e pratiche Taoiste. Perché nella relazione mente-corpo è indispensabile comprendere la differenza tra consapevolezza e controllo, che spesso confondiamo? Perché nelle pratiche psicocorporee e meditative dovremmo sostituire la parola ‘mente’ con il termine ‘mente-cuore‘? Quali sono le […]
LeggiNon siamo più in grado di fare molte posizioni di yoga, e forse non è un male
Esisterà ancora, come sembra da certi annunci, qualcuno che si iscrive a un corso di yoga per togliersi la soddisfazione di fare la spaccata a quarant’anni suonati. La realtà dei fatti, però, è ben diversa, e chi insegna questa disciplina potrà riconoscersi in quanto segue con la sua statistica, personale ma a suo modo significativa: per la gran parte delle persone che si rivolgono allo yoga, oggi, molte delle posizioni più iconiche non sono realizzabili né lo saranno dopo uno, cinque, dieci anni di pratica se non con molti adattamenti e molta fantasia.
LeggiYogasana 6: la pratica in presenza di patologie
Stage per insegnanti e praticanti – febbraio-aprile 2023: come lo yoga può aiutare a vivere meglio in caso di asma bronchiale, ernia iatale, disturbi mestruali, scoliosi, diabete, ipertensione arteriosa e sclerosi multipla.
LeggiUddiyana bandha e il vuoto addominale
Uddiyana bandha, grazie al suo potenziale riabilitativo e con il nome di vuoto addominale o ginnastica ipopressiva, si sta diffondendo anche fuori dallo Yoga una delle sue pratiche più peculiari, in cui però è difficile separare la componente corporale da quella psichica. Ecco perché, anche praticato come gesto atletico, Uddiyana bandha non può essere soltanto […]
Leggi