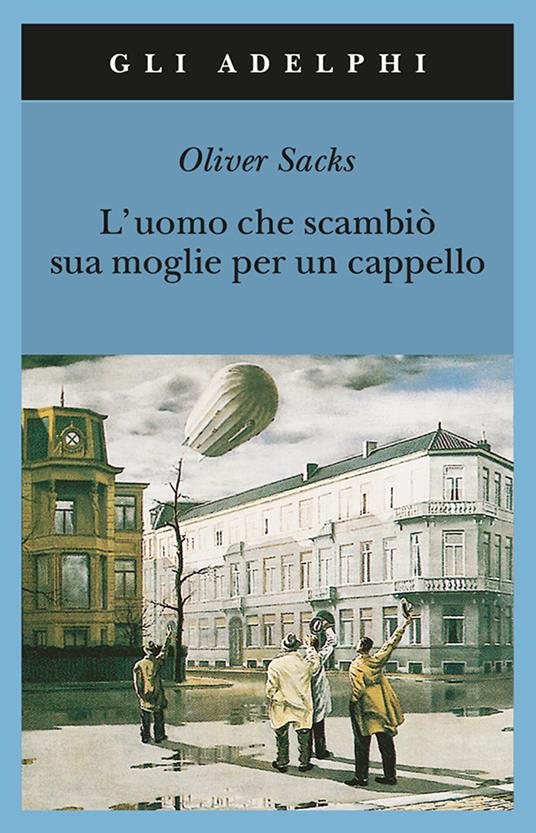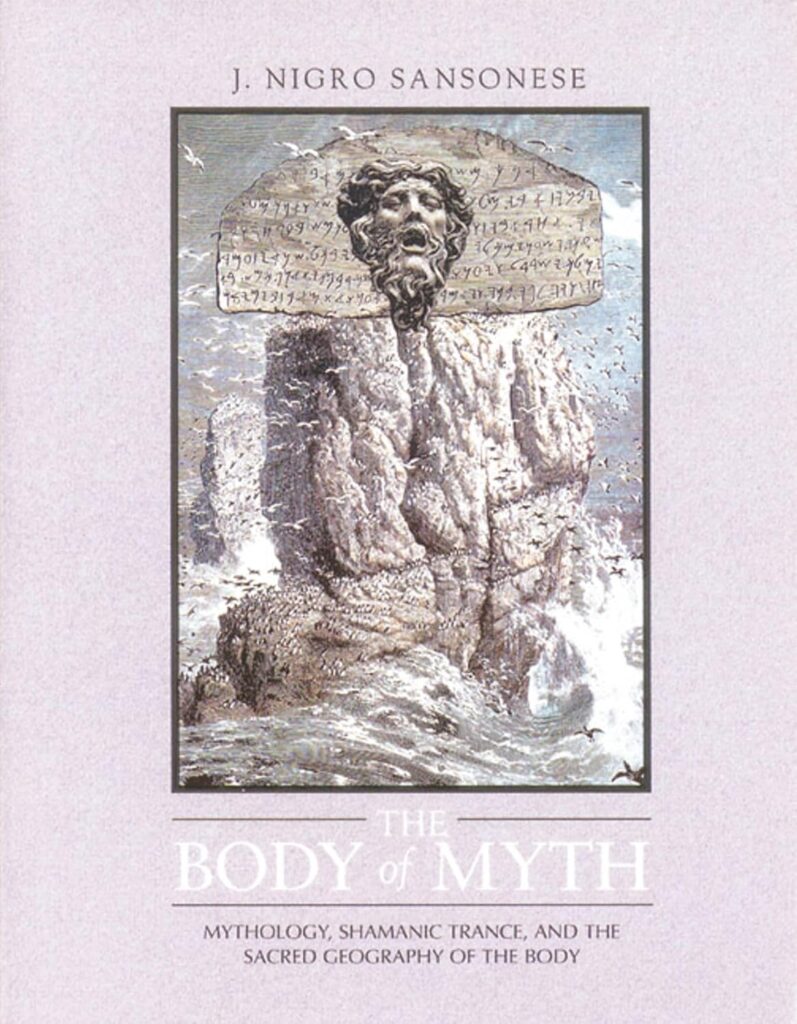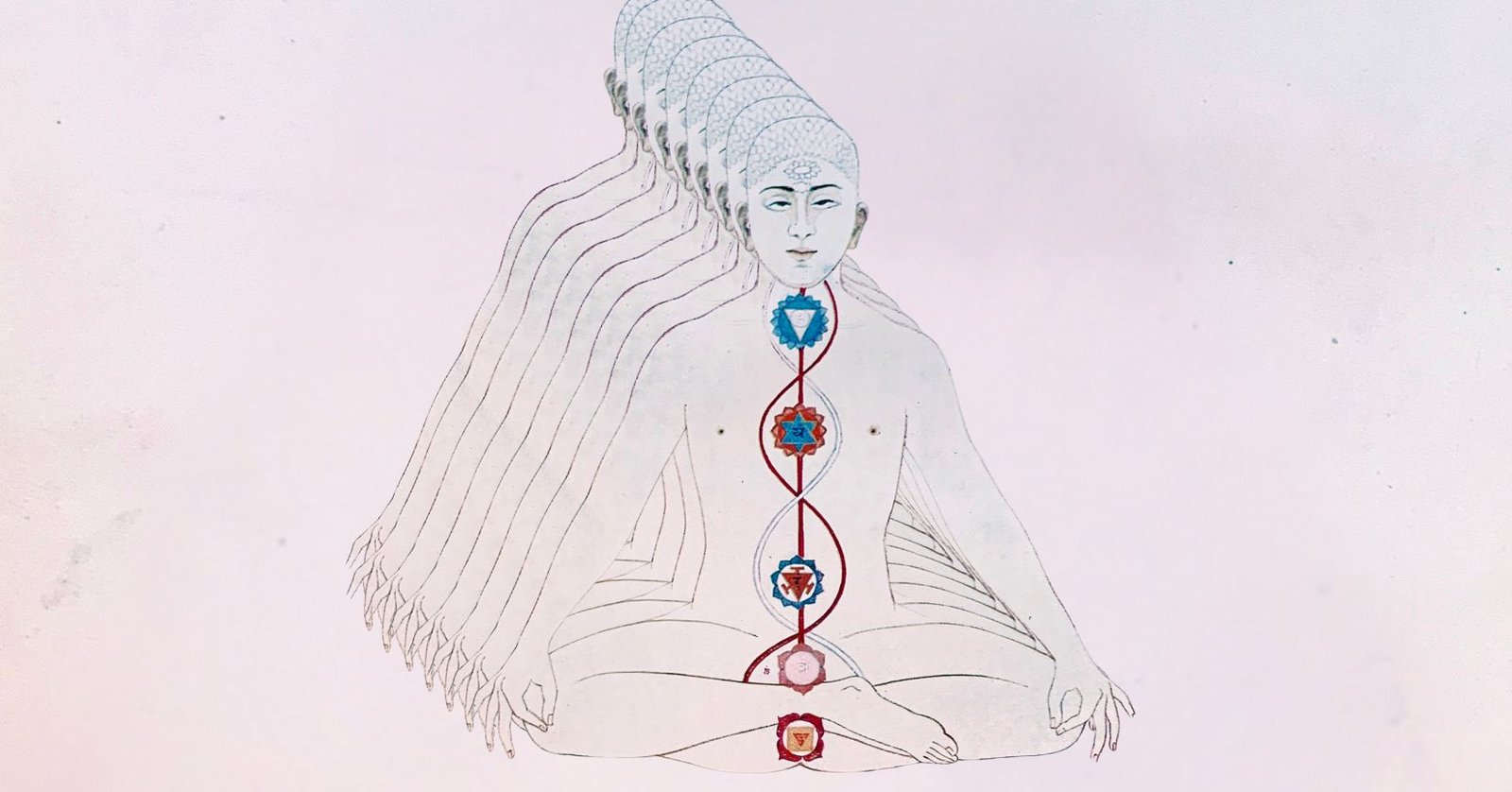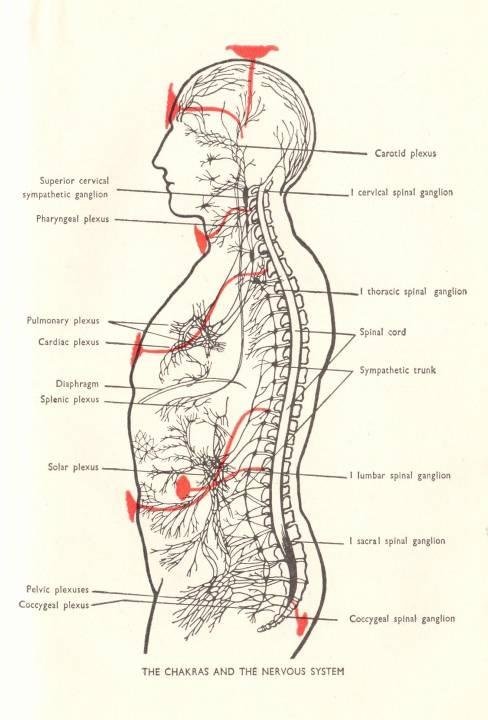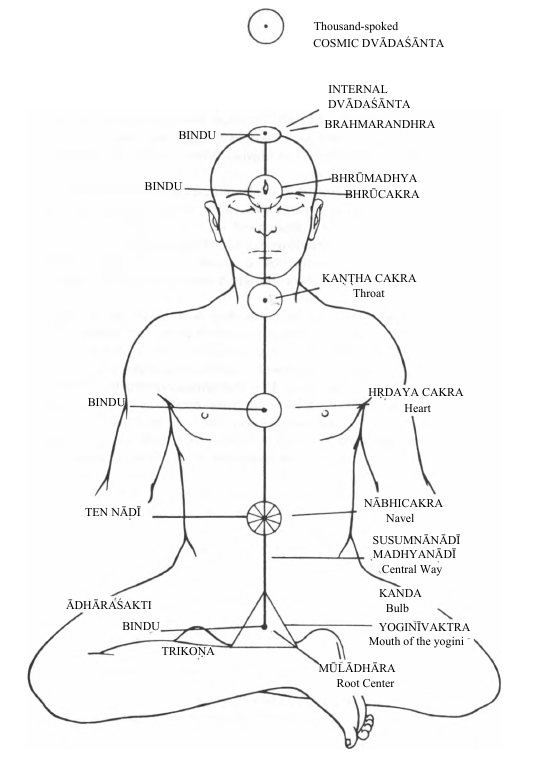Come orientarsi nella selva di yoga-qualcosa riducendo le opzioni a due

Il mercato ci ha persuasi che nello yoga oggi esistano molti stili (attenzione: stili, ovvero brand, non necessariamente tradizioni). Tutti, o quasi, affermano di attenersi a un testo-radice che è essenzialmente un manuale di meditazione e che dedica pochi cenni – anche se pregnanti – alla posizione del corpo; e tutti, o quasi, sono essenzialmente metodi per eseguire posizioni corporee che dedicano poco spazio, o nessuno, alla meditazione.
Ora, esistono ragioni storiche per questo. E ragioni storiche comportano variazioni di rotte, riletture e contraddizioni a cui talvolta non è immune nemmeno la più rinomata tradizione.
Ma siccome qualsiasi insegnante affermerà che lo yoga è molto di più che fare posizioni, e siccome quel molto-di-più ha la sfortuna di non essere altrettanto evidente, proponiamo una macro distinzione per orientarci nella selva di yoga-qualcosa e di qualcosa-yoga che molto spesso ridondano più che variegare l’offerta: la distinzione tra chi ritiene che la posizione sia un mezzo e chi la ritiene un fine.
Partiamo da quest’ultimo caso, ovvero quello più problematico, chiedendo pazienza se questa prima parte sarà soprattutto destruens, ma si tratta di una premessa necessaria per la fase costruttiva.
Intendere la posizione come fine potrebbe avere un’accezione tutt’altro che negativa: il corpo come strumento di liberazione1 da un lato e la totale dedizione all’azione dall’altro sono elementi che appartengono alla tradizione yogica e indiana in generale, checché ne dicano alcuni soloni.
Tuttavia, la posizione intesa come scopo, così come si presenta oggi, è l’esatto contrario dell’esperienza reale del corpo, e l’azione che comporta è priva del disinteresse e dell’equanimità di fronte a vittoria e sconfitta predicati dalla Bhagavadgītā.
Quando è un fine, infatti, la posizione è calata astrattamente dall’alto e decontestualizzata. Si fa perché facendo yoga bisogna fare trikonasana, bisogna fare le capovolte o gli equilibrismi sulle mani, la spaccata o chaturanga dandasana (notare, quasi mai le posizioni meditative vengono citate tra le più impegnative o le più avanzate).
Quando la posizione è un fine, sei tu a doverti adattare anche di fronte a una evidente incongruenza tra l’ideale della posa e la tua configurazione fisica, tra il precipitarsi verso un risultato e ciò che deve essere fatto ora per ristabilire l’ordine nel tuo corpo (il tuo dharma corporeo, potremmo dire), vanificando qualsiasi disposizione all’ascolto, vale a dire del tanto celebrato momento presente che è impossibile senza porgere orecchio al corpo.
Nel momento in cui sto tendendo verso qualcosa che non c’è, o sto lottando per evitare di perderlo, che cosa posso sentire, organicamente, del corpo, che ne è del mio respiro, che ne è del qui ed ora?

Comprendiamoci: un confronto con la difficoltà, o con il semplicemente altro dal conosciuto, è sempre necessario per poter crescere. Ma quando la posizione è un fine, ti capiterà di dover diventare un po’ quadrato anche se sei nato tondo, e ti troverai a tirare dritto anche là dove sentirai che fisiologicamente c’è una curva. E anche se sei nato quadrato, ma i tuoi angoli si sono slabbrati con l’età, ti verrà chiesto di comportarti come se avessi ancora gli spigoli vivi.
In altre parole, se la posizione è un fine, verrà fatto appello a caratteristiche che solo alcune fisicità possiedono, ovvero a quelle caratteristiche che permettono il suo manifestarsi più estremo, favorendo anche condizioni, come ad esempio l’ipermobilità articolare, che andrebbero invece circoscritte lavorando più sulla contrazione muscolare e sulla forza.
Quando la posizione è un fine, i supporti che ti verranno dati saranno delle protesi per supplire alla tua diversa abilità, e gli adattamenti saranno dei ripieghi che non offriranno gli stessi benefici della posizione piena (almeno così verrà inteso).
Già, perché, quando la posizione è un fine, esiste una posizione finale, che è un po’ come la soluzione finale: per raggiungerla è giustificato qualsiasi mezzo, dall’afferrare membra e strattonarle come se non fossero parte del nostro corpo, a sottoporci a ogni sorta di aggiustamento da parte di terzi con lo scopo di farci entrare, appunto, ancora di più nella forma finale e ideale.
Ed è un continuo estendere, allungare, stirare, aprire senza che nessuno si preoccupi anche di chiudere, con buona pace dell’equilibrio o superamento degli opposti.
È perciò inevitabile che, quando la posizione è un fine, i praticanti si guardino l’un l’altro, e stabiliscano dei paragoni, nonostante i tanti discorsi sulla non competitività: la stessa suddivisione tra principianti ed avanzati molto spesso si basa su criteri fisici quantitativi, e seleziona a sua volta una classe di insegnanti sulla base della flessibilità che non ha necessariamente la tempra e i requisiti attitudinali per questo ruolo.
Insomma, quando la posizione è un fine c’è sempre un ‘meno’ da colmare e un ‘più’ che si sottrae tantalicamente alla nostra portata (perché il corpo, come tutto ciò che è materiale, è così: si ribella all’ideale moltiplicando i casi particolari, irride la regola sfornando eccezioni).

Raramente sorge il dubbio che il cammino lungo il quale celebriamo i nostri traguardi (gamba dietro la schiena, arcuazione esponenziale, equilibrio sulle dita), non sia invece lo stesso loop a ripetersi costantemente, alla ricerca di qualcos’altro, qualcosa di più, che non sarà mai quello, che non avrà mai l’essenziale che cerchiamo veramente.
Quando è un fine, è la posizione in sé ad avere dei benefici, così come illustrato nei manuali con una certa serialità: ieri rinforzava il rachide, apriva il torace e il bacino, oggi massaggia la fascia e attiva il nervo vago.
E se è la posizione in sé ad avere benefici, non poter fare una posizione è un problema, sia per la progressione nello yoga, sia (diranno) per il benessere e la salute del praticante.
Ed è qui che suona il vero campanello di allarme, ovvero il quasi inevitabile incontro con l’infortunio, che accade più spesso facendo la posizione piuttosto che non facendola, e che in situazioni sane dovrebbe essere accolto come un richiamo alla realtà dopo tanto scollamento. Se la posizione è un fine, capiterà invece di sentirsi dire che l’infortunio è parte del cammino, ed è inevitabile se si pratica con costanza.
O addirittura che è un processo di guarigione: il che, diabolicamente, potrebbe essere anche vero, se la diagnosi si basasse su una reale cognizione delle cause e non sul principio di autorità, ovvero che la posizione e le istruzioni per arrivarci sono da prendere alla lettera e non ammettono contraddizioni e deroghe.
Questa capriola tra cause ed effetti, questa dissonanza cognitiva è tipica dei sistemi chiusi che cercano di conservare sé stessi. Purtroppo molto spesso quando il sistema crolla, per confronto con l’evidenza o per cedimento strutturale irreversibile, subentra il rigetto totale.
Anche per questo, da qualche tempo registriamo – statistiche personali – un crescente numero di persone interessate alla meditazione ma che si rifiutano di prendere in considerazione di praticare dello yoga, perché scottati da esperienze regresse incompatibili con un contesto contemplativo. O che si rivolgono ad altre discipline psicofisiche (Qi Gong, Tai Chi, forme moderne di movimento consapevole) perché interessate a una pratica che permetta di vivere una reale connessione e integrazione corporea.
A costoro, purtroppo, non è sempre possibile comunicare che esiste anche un altro yoga, e li comprendiamo. Vale la pena di dirlo, però, nel seguito di questo articolo.
- Per quanto riguarda l’azione non serve nemmeno citare la dottrina del karma yoga espressa nella Bhagavadgītā (con le riserve espresse poco più avanti nel testo). Per quanto riguarda la centralità del corpo, sono indizi abbastanza significativi non solo il fatto che fin dal Ṛgveda il cosmo sia rappresentato come corpo e il corpo sia interpretato come microcosmo, ma vorrei ricordare una nota di Raffaele Torella: “Mi trovavo nell’estate del 2004 a Helsinki per la World Sanskrit Conference. Assisto a una relazione di Rama Nath Sharma, illustre studioso di grammatica sanscrita e di scienze del linguaggio, nella quale mi colpisce una citazione tratta apparentemente dal Dharmasastra, il vastissimo corpus di testi che da sempre regolano il comportamento socioreligioso dell’hindu ortodosso. In essa Si faceva menzione del corpo come primario mezzo per la realizzazione del dharma. Incuriosito, a fine conferenza avvicino il collega indiano indiano per chiedergli quale ne fosse la fonte specifica. Sharma mi risponde (accompagnando la sua risposta con un vago sorriso di intesa): «But everybody knows…»” (da da Eros, passioni, emozioni nella civiltà dell’India, Carocci, 2023, pp. 93-94 n.38). ↩︎