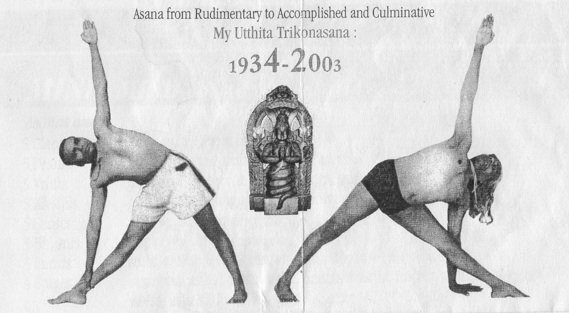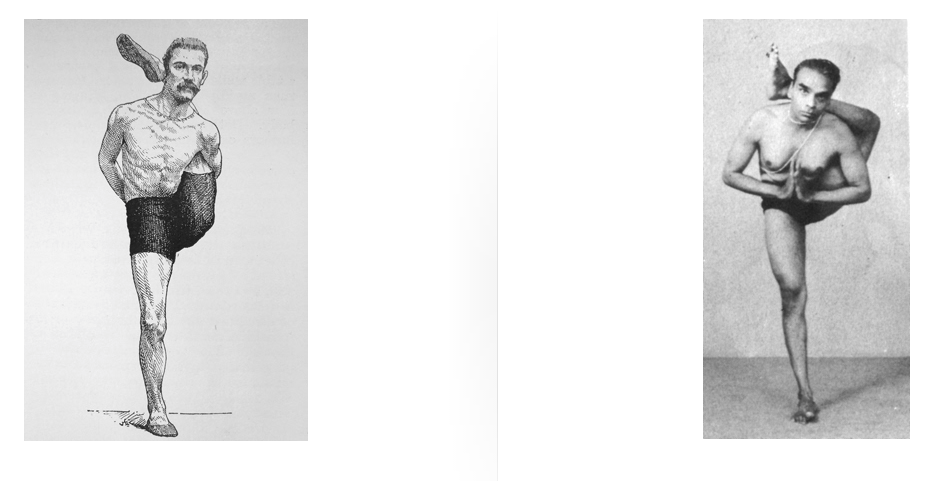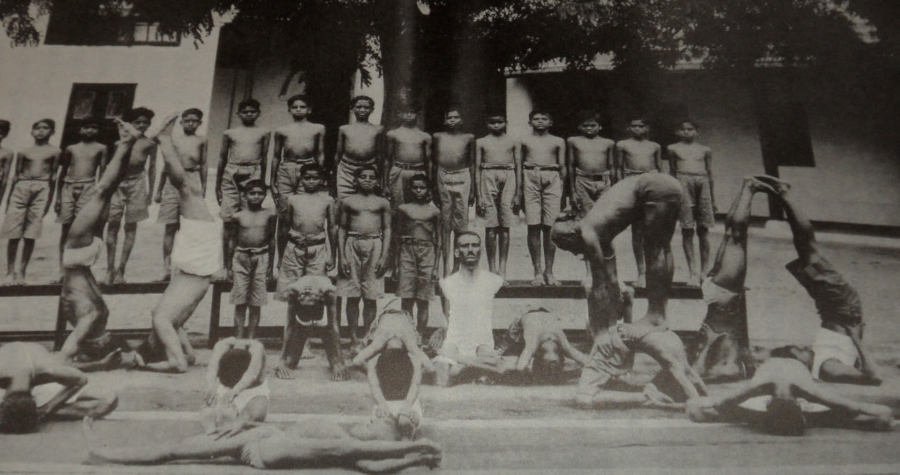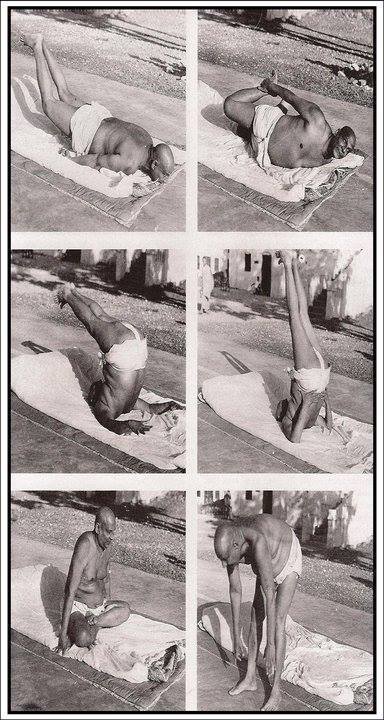Oggi vi è molta attenzione agli aspetti anatomici e biomeccanici degli āsana yogici, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di adattarne la pratica a un pubblico di massa, con tutta la varietà di condizioni fisiche che questo comporta.
Tuttavia, questi aspetti, pur essendo oggi imprescindibili per la pratica e per l’insegnamento, non bastano a spiegare il perché e il come della pratica corporea all’interno dello yoga, che ha come obiettivo non solo l’integrazione dell’insieme corpo-mente, ma il superamento di esso (ovvero: non sono né il corpo né la mente, ma ne sono lo spettatore).
La questione però non riguarda soltanto il quadro teorico e dottrinario entro cui la pratica yogica è tradizionalmente inserita, che peraltro, come spesso abbiamo rilevato, può variare anche in modo significativo. Da un punto di vista strettamente pratico, infatti, i sistemi coinvolti nella pratica degli āsana non sono esattamente gli stessi che vengono coinvolti nell’esercizio fisico comunemente inteso, anche se occasionalmente possono coincidere.
Ad esempio, i concetti di ‘sovraccarico funzionale’ (ovvero lo stress che fornisco al corpo per produrre un adattamento) e di ‘soglia aerobica’ (il momento in cui si ‘rompe il fiato’ passando dal metabolismo anaerobico a quello aerobico) non sono esattamente applicabili allo yoga, che tendenzialmente mira, anche nel sovraccarico, a rallentare il metabolismo energetico piuttosto che accelerarlo, complice, oltre alla ricerca dell’agio persino nello sforzo, la particolare regolazione del respiro: controllo dell’addome e filtraggio alla glottide (ujjayi), estensione delle fasi respiratorie, con conseguente diminuzione del consumo di energia laddove l’esercizio fisico tende temporaneamente a incrementarlo. In altre parole, se pratichiamo āsana anche per ore non varcheremo mai la soglia aerobica, ma non possiamo dire nemmeno che sfrutteremo i processi anaerobici.
Eppure, nonostante si muova secondo modalità che per il comune modo di pensare sarebbero improduttivi, la pratica degli yogāsana produce anche una profonda risposta fisiologica e un notevole effetto di ritorno sulle prestazioni fisiche. E inoltre, un’importante conquista mentale, ovvero la capacità di trovare la stabilità anche nei momenti di maggiore sollecitazione ed eccitazione: non sono né il corpo, né la mente, ma ne sono lo spettatore.
Da cosa dipendono queste differenze? È possibile, nel caso degli āsana, parlare di energia esclusivamente come biochimica (ATP) o dovremmo ricorrere al concetto di energia come… prana? Ammettendo quest’ultima ipotesi, come evitare la vaghezza olistica e l’autosuggestione da un lato, e le alzate di spalle degli scettici dall’altro?
Non è qui il luogo per dare risposte troppo definite, che rischierebbero di creare inutili sovrastrutture e aspettative. Possiamo constatare però che quando togli l’alimentazione e la macchina continua ad andare, significa che il carburante – forse un altro tipo di carburante – ha iniziato a circolare per altre vie. Allo stesso modo, praticando gli āsana si impara progressivamente a utilizzare meno la forza fisica, e più qualcos’altro. Che poi questo qualcos’altro, risalendo molto a monte, sia a sua volta la fonte anche della forza fisica, è un’altra storia ancora.
Anche per questo, durante una lezione di yoga si può assistere spesso a un curioso capovolgimento: praticanti fisicamente ‘dotati’ che arrancano da un lato perché avvezzi alle modalità contrattive; e, dall’altro, praticanti che ‘sulla carta’ dovrebbero essere svantaggiati che invece scoprono inaspettate abilità e libertà dai vincoli gravitazionali.
Ed ecco che a volte è possibile prendersi alcune licenze rispetto a ciò che il chinesiologo raccomanderebbe (ovviamente, chi ci conosce sa che non intendiamo con questo giustificare indiscriminatamente qualsiasi prassi solo perché presentata sotto il cappello yogico).
Potremmo quindi concludere provvisoriamente che lo yoga non solo serve a ‘riabilitare gli invalidi’ (invalidità che Giorgio Invernizzi nell’articolo precedente intendeva a un livello ancora più a monte), ma anche a rivedere i canoni – spesso viziati da logiche devianti – che definiscono l’abilità.
Nel riconoscere la propria inadeguatezza, sorge la vera forza, e quando non sai nemmeno da dove arrivi di preciso, allora significa che non può realmente venire meno.
________________
PS: naturalmente, dato l’ampio ventaglio di declinazioni dello yoga presenti sul mercato, non sempre si incontrerà una pratica che collima con quanto descritto più sopra, in quanto alcuni ‘stili’ propenderanno più verso una pratica aerobica. Senza voler sollevare il dibattito su cosa sia ‘più yoga’ di altro (e senza voler attribuire quanto detto a una specifica scuola o brand), rimandiamo al nostro vecchio articolo Lo yoga in una posizione per inquadrare meglio dal punto di vista storico e filosofico la pratica degli āsana all’interno dello yoga.
Leggi