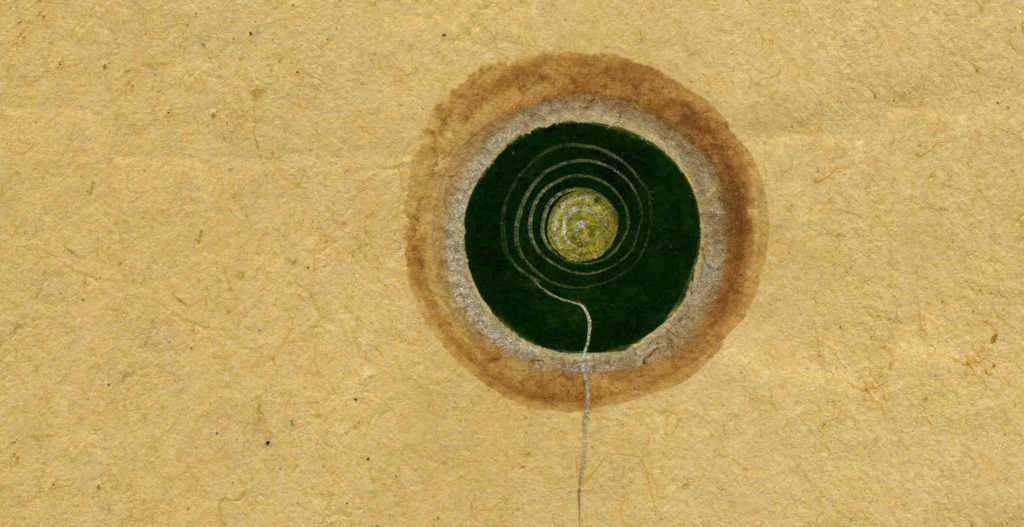Ci siamo accorti che dopo molti anni e fiumi di parole mancava su questo blog un articolo che parlasse della meditazione in termini basilari, senza omettere gli aspetti più pratici per chi volesse accostarsi a questa pratica che singolarmente prevede – o mira a – l’assenza di attività. Mancanza quasi imperdonabile, visto che l’argomento stesso esige che nulla sia scontato o banale e che ogni volta si parta come la prima.
Con questo articolo vogliamo quindi colmare la lacuna, con l’intento di fornire degli elementi-chiave con cui orientarsi, con la consapevolezza che anche questa è una bella responsabilità, perché nella meditazione come nella realtà non ci sono livelli: la versione per principianti contiene già il tutto.
Leggi