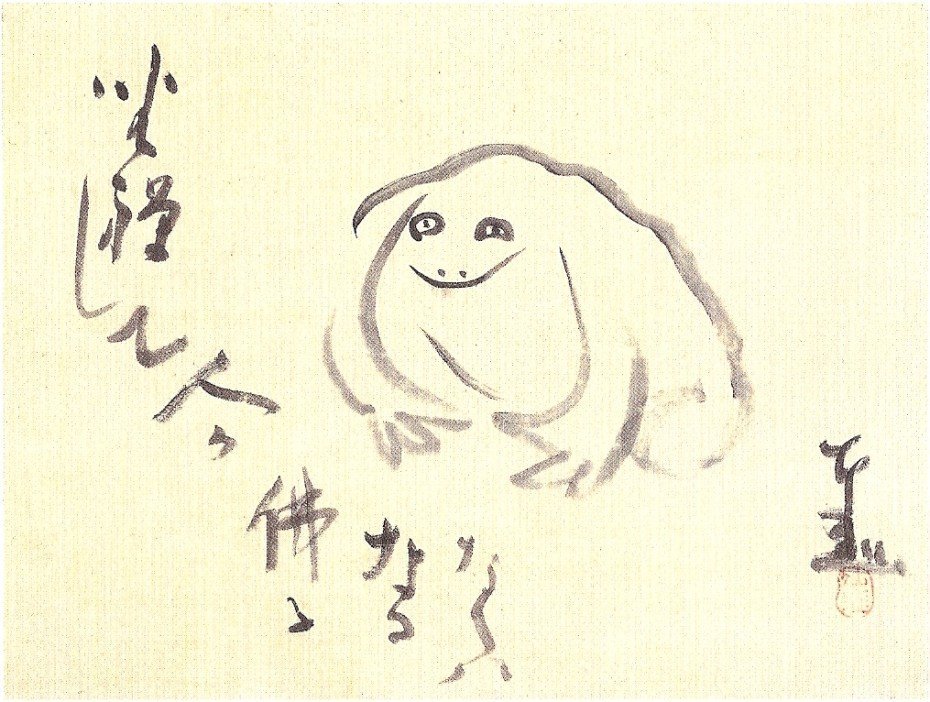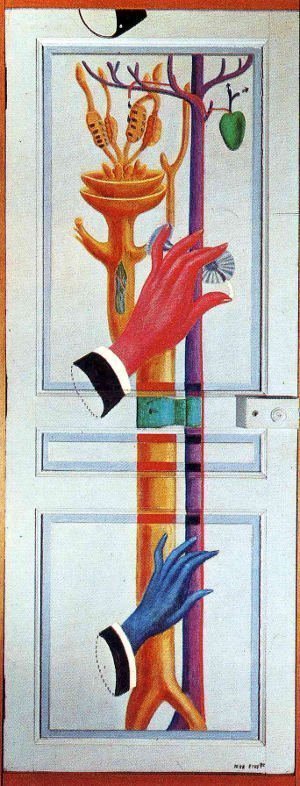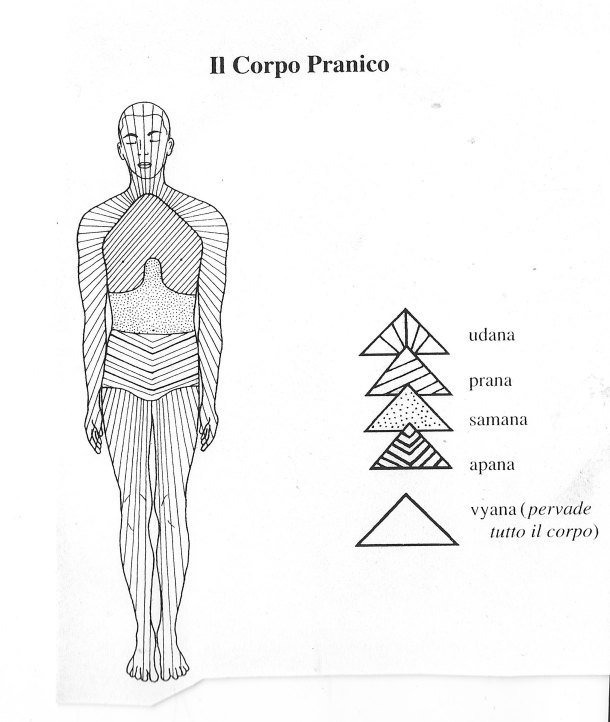Una piccola premessa
Quanto segue è nato da una ‘intervista andata male’ per un quotidiano nazionale alcuni anni fa. Una giornalista ci aveva chiesto di fornire alcuni pareri sugli aspetti critici del mondo dello yoga, con l’evidente intenzione di realizzare un articolo provocatorio che facesse rumore.
Si sa però che le provocazioni troppo artefatte raramente riescono nel proprio intento: purtroppo l’intervista fu parecchio distorta rispetto a quanto avevamo in realtà detto (e ci sentiamo estremamente imbarazzati nello scrivere quella che sembra ‘la solita scusa’, ma andò proprio così) e fu mescolata a frasi decontestualizzate tratte da nostri articoli. Ci fu però chiesto anche di redigere un elenco di ‘consigli’ per i praticanti che accompagnasse una galleria a corredo dell’articolo. Ciò che segue è il risultato di varie elaborazioni di quella stesura originaria.
Col passare del tempo, l’intento originale ha subito delle evoluzioni e anche il significato di ‘rischio’ è mutato.
Si parla molto – e a ragione – dei rischi legati alla pratica dello yoga in un’epoca in cui questa pratica è divenuta di massa, e pertanto si rivolge a un pubblico molto più vasto e meno interessato agli aspetti profondi. È ormai chiaro che far eseguire le stesse tecniche nello stesso modo a chiunque è impensabile. Ma giungere alla conclusione che la pratica debba essere adattata non è una menomazione dello spirito originario dello yoga, bensì un’occasione per coglierne l’essenza, che non risiede in una tecnica.
Per questo, abbiamo voluto ‘giocare’ con il significato di rischio nelle considerazioni contenute nell’elenco che segue: laddove evidenziando i rischi si pensa – sempre a ragione – di salvaguardare la propria incolumità, abbiamo voluto porre l’accento invece su un altro tipo di rischio: la possibilità di cogliere qualcosa di inaspettato, di lasciarsi sorprendere da un effetto collaterale che nei manuali di yoga, spesso infarciti di benefici e di finalità, non è pronosticato: sentirsi qui, all’improvviso e totalmente, in qualsiasi condizione ci si trovi e su qualsiasi gradino si pensi di transitare.
Qualche consiglio

- Lo yoga è accorgerti che non sei tu a respirare, non sei tu a muovere il tuo corpo, non sei tu a pensare. Inizialmente, ciò può sembrare una terribile perdita di controllo; ben presto avrai modo di ricrederti sulla tua stravagante idea di controllo.
- Il termine yoga può avere accezioni molto diverse a seconda delle tradizioni, dei metodi di insegnamento e delle persone stesse che le praticano: constata questa varietà, queste apparenti contraddizioni, ovvero il fatto che è così ma potrebbe anche essere altrimenti.
- Perciò, non spendere troppa energia per capire chi sia arrivato prima o chi sia più fedele a una tradizione: la ‘tradizione’ non è fare le stesse cose oggi come ieri, ma fare oggi ciò ti permette di sentire l’essenziale, che non risente del tempo.
- Prova pure diversi tipi di yoga, diversi insegnanti, diversi insegnamenti, ma evita la superficialità del ‘mordi e fuggi’: se senti qualcosa, fermati e dagli del tempo.
- Qual è il significato di ciò che sto facendo, a che cosa devo pensare mentre eseguo questa pratica? A volte, è meglio lasciare in sospeso la domanda, e ascoltare lo spazio lasciato dall’interrogativo. Se non c’è alcun senso (per te in questo momento) non tarderà a essere evidente. Se c’è, difficilmente risiederà in una formulazione.
- Nello yoga ciò che che conta è soprattutto l’atteggiamento, prima che la tecnica in sé. Questa attitudine è ascolto senza valutazione, perché l’oggetto dello yoga, se così si può dire, è Coscienza. La disponibilità all’ascolto può risolvere alla radice migliaia di dettagli; la sola tecnica può unicamente afferrarli nei loro aspetti periferici.
- Ogni tecnica, in realtà, è un espediente per realizzare che nessuna tecnica è essenziale. A volte, l’unico scopo è tenere occupata la mente dall’intervenire in ciò che accade da sé.
- Anche questo è un enorme lavoro e richiede di sviluppare una grande sensibilità.
- Come faccio a distinguere se sto ascoltando veramente, oppure sto pensando di sentire? È più facile se presti ascolto a ciò che normalmente non vuoi constatare, quando senti il tuo stesso non voler sentire.
- Sentire una tensione, sentire la propria rigidità non è il problema, ma il principio. A volte la rigidità più ostinata è voler eliminare la tensione: includi nell’ascolto anche il tuo sforzo di quietare lo sforzo, senza giudicarlo.
- Non alzare il volume per sentire meglio, ma affina l’udito. Vale per tutti i sensi.
- Occorrono degli accorgimenti e delle precauzioni per praticare le tecniche dello yoga, soprattutto in condizioni fisiche particolari, ma il primo accorgimento è sviluppare un’attenzione rivolta alla totalità dell’esperienza: senza di essa, nessun’altra precauzione può essere efficace.
- Pretendere un risultato è la prima causa di infortunio. Ma questo non sia un alibi per non provarci nemmeno.
- Lo yoga inizia quando si è indifferenti a perdita e guadagno: a volte però le ‘perdite’ portano a conseguenze ben più interessanti.
- Nello yoga non c’è un punto di arrivo. Però, quando il tuo corpo, il tuo respiro o la tua mente si arrestano, vai oltre, lascia che l’ascolto prosegua nelle correnti, nei punti di fuga, nei prolungamenti fino a che la distinzione tra te e non-te diventa irrilevante.
- Che cosa succede allora quando si riconosce il proprio non sentire? Si sviluppa, a volte in modo straordinario, un’altra sensibilità, una diversa abilità. E proprio qui comincia lo yoga vero.
- In realtà, in qualsiasi punto ti trovi, quello è il luogo. Non sperimenterai “il vero yoga” quando sarai più bravo o avrai più esperienza, ma quando realizzerai in modo permanente la tua inettitudine, la tua impotenza, la tua inconcludenza. A volte, ‘essere bravo’ significa esserne schiavo.
- La tranquillità è la condizione necessaria per praticare yoga: arriva quasi sempre quando smetti di cercarla.
- Nelle posizioni, gli allineamenti hanno la loro importanza, ma solo se ti permettono di sentire il tuo corpo integralmente. Se diventano un’ossessione per il particolare e per la perfezione, confermano soltanto la percezione ‘spezzata’ di te e la frammentazione dell’attenzione.
- Le posizioni complesse, che spesso vedi esibite come trofei nelle foto di insegnanti e praticanti, non sono traguardi da conquistare, né sono per forza l’attestato di una pratica avanzata. Spesso hanno effetti molto particolari che vanno al di là dell’abilità fisica e non sono consigliabili a tutti né sono adatte ad ogni occasione della vita.
- Se non hai dimestichezza con l’attività fisica, dovrai abituarti a percepire la leggerezza che emerge anche dalle sensazioni di un corpo che ha faticato. Se sei abituato/a all’attività fisica, dovrai abituarti a percepire la fisicità anche quando apparentemente non stai facendo alcuno sforzo.
- Non credere tuttavia agli idioti secondo cui bisogna soffrire.
- Diffida dei culti della persona, delle persone tutte d’un pezzo e delle dinamiche settarie, ma non cercare di vedere questi fenomeni per forza dappertutto. Rallegrati che il tuo insegnante abbia dei difetti quando non nuocciono agli altri, ma non cercare altre giustificazioni oltre al fatto che è un essere umano.
- Per praticare yoga non sei obbligato a diventare vegetariano o vegano: i cambi di alimentazione e nelle preferenze verranno da sé, come constatazione, non aderendo a ideologie.
- Ricorda che l’insegnante non è un sostituto del medico o dello psicoterapeuta e lo yoga non sostituisce le cure mediche o il supporto psicologico. Tuttavia,la pratica può essere terapeutica.
- Le tecniche dello yoga non sono nemmeno pillole per risolvere questo o quel problema fisico. Possono aiutare, ma non sempre l’aiuto sortisce l’effetto che si era pensato in principio. A volte, può darsi che un disturbo scompaia, o passi sullo sfondo, fino a diventare irrilevante: ma non cercare mai questo risultato intenzionalmente.
- Le tecniche dello yoga non sono nemmeno pillole per risolvere questo o quel problema fisico. Possono aiutare, ma raramente l’aiuto sortisce l’effetto che si era pensato in principio. A volte, può darsi che un disturbo scompaia, o passi sullo sfondo, fino a diventare irrilevante: ma non cercare mai questo risultato intenzionalmente.
Tutte le immagini in questo articolo sono di Daniel O’Neill.
Leggi