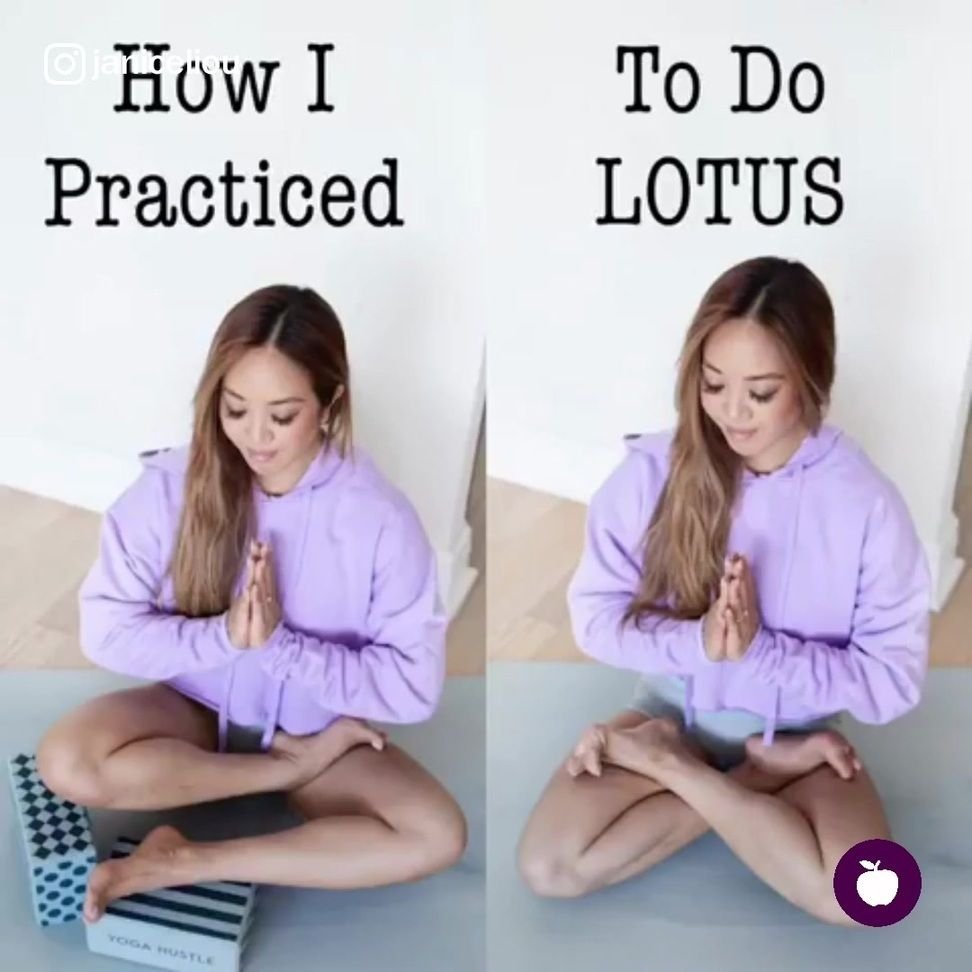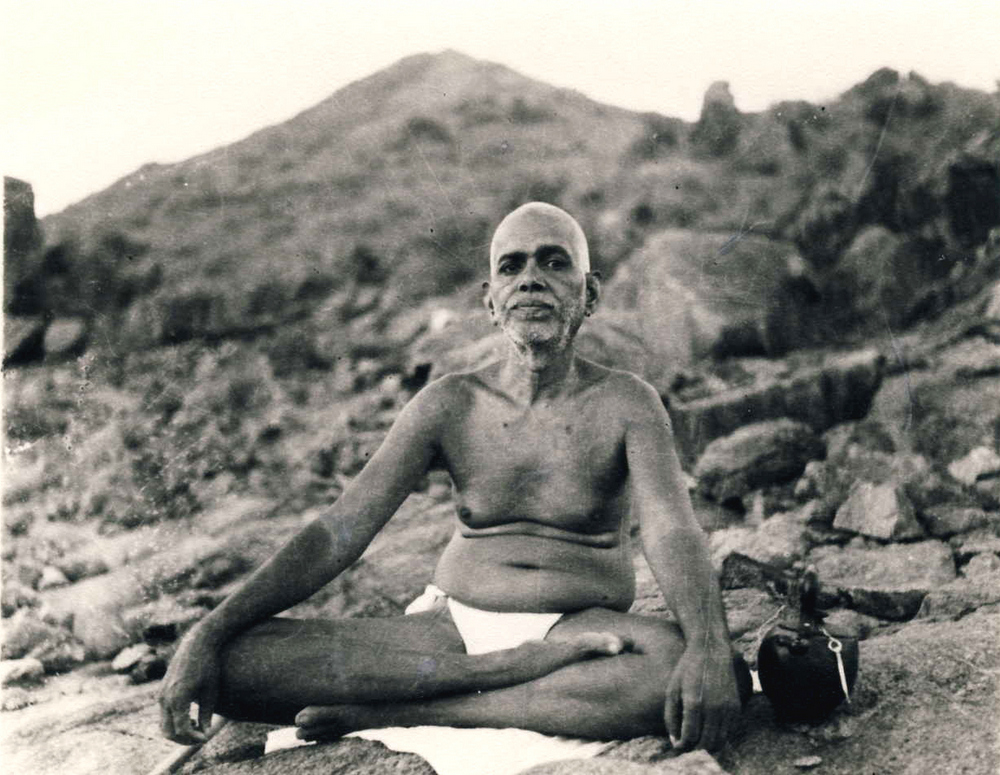Il Tai Chi Chuan (o Tai ji Quan usando la traduzione degli ideogrammi cinesi con lo standard “pinyin”) è una pratica che nasce in Cina dall’incontro tra arti marziali e pratiche tradizionali per la salute e la longevità.
Non vi è chiarezza sulle sue origini che pare siano contenute nelle antichissime radici stesse della cultura cinese. Alcune leggende infatti fanno risalire la nascita di questa pratica al V° secolo e a Bodhidarma, il monaco buddista che dall’India si recò in Cina portando con sé l’insegnamento Buddista e fondando il monastero di Shaolin. Altre leggende lo fanno risalire al X° secolo ad opera dell’eremita taoista Zhang San Feng che viveva sul monte Wudan. Testimonianze invece concrete riguardo la sua codifica negli stili moderni risalgono al XVIII° secolo con lo stile della famiglia Chen, tra i principali stili presente a tutt’oggi e praticato.1Carlo Moiraghi, Tai Ji Quan, la forma breve e la forma lunga, Edizioni XX

Il Tai Ji Quan è un’antica disciplina che permette di armonizzare e di ottimizzare il proprio stato vitale ed il proprio flusso energetico attraverso l’uso combinato di movimenti lenti e armonici e un uso consapevole del respiro. Per questo motivo è parte fondamentale delle pratiche tradizionali cinesi della prevenzione e della longevità e, a buon titolo, fa parte in maniera integrante del corpus medico tradizionale cinese.
Oltre all’aspetto salutistico-preventivo, il Tai Ji Quan contiene anche un aspetto marziale e in esso sono contenute e fuse insieme le complesse e multiformi radici culturali da cui nasce la cultura cinese e il suo corpus medico, cioè Buddhismo, Confucianesimo e Taoismo. Le sue più evidenti diversità rispetto ad altre arti marziali sono costituite dal ruolo centrale assegnato ad azioni difensive basate sulla cedevolezza, e dall’impiego nei confronti dell’avversario della elasticità del corpo invece che della forza.2Carlo Moiraghi, Tai Ji Quan, la forma breve e la forma lunga, Edizioni XX
Da alcuni anni è andato crescendo l’interesse della medicina occidentale verso questa pratica, intuendone il potenziale benefico in numerose patologie. Infatti diversi studi hanno evidenziato come il Tai Chi Chuan possa portare a significativi miglioramenti o comunque a dei benefici nelle patologie più disparate, dall’osteoporosi, ad alcune malattie neurologiche, fino a patologie cardiovascolari e polmonari croniche.3Leung RW, McKeough ZJ, Alison JA. Tai Chi as a form of exercise training in people with chronic obstructive pulmonary disease. Expert Rev Respir Med. 2013 Dec;7(6):587-92
Questo perché? Il mondo scientifico occidentale, e in particolare l’OMS, nel tentativo di catalogare tutto ciò che è considerabile come tecnica terapeutica ma “alternativa” alla medicina occidentale basata sulle evidenze, ha introdotto una complessa categorizzazione di cui fa parte anche la medicina tradizionale cinese e quindi il Tai Chi, definito come tecnica “psico-corporea”.4NCCAM, National Center for Complementary and Alternative Medicine
World Health Organization 2000: General guidelines for methodologies on research and evaluation of traditional medicine, Geneva, WHO, 2000.
Il Tai Chi Chuan appartiente a tale categoria proprio perché a differenza di una attività fisica generica non si focalizza soltanto sull’attività muscolare finalizzata al movimento, ma anche su altri aspetti come la respirazione, il mantenimento di una postura corretta, l’equilibrio, l’eliminazione di rigidità fisiche e di tensioni mentali, il tutto finalizzato a generare un’armonia tra corpo e mente, giustificando quindi appunto la definizione di tecnica psico-corporea.

Recentemente è stata pubblicata una ricerca sulla rivista New England Journal of Medicine,5Li F, Fisher KJ, Harmer P, Irbe D, Tearse RG, Weimer C. Tai Chi and self-rated quality of sleep and daytime sleepiness in older adults: a randomized controlled trial. J Am Geriatr Soc 2004;52:892-900 una delle più autorevoli dal punto di vista scientifico per quanto riguarda la medicina occidentale basata sulle evidenze.
Questo studio randomizzato controllato, svolto dall’Oregon Reasearch Institute e finanziato dal fondo di ricerca nazionale statunitense (NIH), aveva come obiettivo il determinare se un programma di Tai Chi potesse migliorare il controllo posturale in pazienti affetti da Morbo di Parkinson.
Il razionale di questo studio si basa sul fatto che alcuni lavori in passato hanno già dimostrato come l’esercizio fisico possa rallentare il deterioramento delle funzioni motorie e prolungare il periodo di indipendenza nei parkinsoniani.6Li F, Harmer P, Glasgow R, et al. Translation of an effective Tai Chi inter- vention into a community-based falls- prevention program. Am J Public Health 2008;98:1195-8 Tuttavia la ricerca è sempre più focalizzata a cercare approcci a metodiche di esercizio alternativo che possano apportare benefici anche in ambito non unicamente motorio.
Per questo i 195 pazienti arruolati in questo studio sono stati suddivisi in maniera casuale in tre gruppi: uno in cui veniva praticato solamente il Tai chi, un secondo in cui veniva svolto un classico programma di esercizi contro resistenza come da linee guida e un terzo gruppo in cui si praticava unicamente stretching. I pazienti di ciascun gruppo eseguivano quindi 2 sessioni di allenamento settimanali della durata di un ora per un totale di 24 settimane.
I risultati di questo studio sono stati sicuramente interessanti, in quanto il gruppo di pazienti trattati con Tai Chi ha dimostrato un miglioramento rispetto agli altri due gruppi statisticamente significativo dell’equilibrio accompagnato da un aumento dell’ampiezza del passo, della velocità del cammino, e conseguentemente una riduzione significativa del numero di cadute.
Quindi il Tai Chi sarebbe in grado di sovvertire i meccanismi che determinano i deficit di movimento e di coordinazione nei pazienti Parkinsoniani producendo contemporaneamente un aumento dell’equilibrio e da ultimo un miglioramento netto nell’espletare le attività del vivere quotidiano.
Secondo gli autori tutto ciò sarebbe ascrivibile a diverse caratteristiche della pratica del Tai Chi ed in particolare alla forma specificamente utilizzata in questo studio che è descritta nell’appendice all’articolo.7Li F, Fisher KJ, Harmer P, Irbe D, Tearse RG, Weimer C. Tai Chi and self-rated quality of sleep and daytime sleepiness in older adults: a randomized controlled trial. J Am Geriatr Soc 2004;52:892-900
Infatti in generale i movimenti del Tai Chi stressano lo spostamento del peso e il movimento delle caviglie mantenendo il centro di gravità dell’individuo ai limiti della stabilità, alternando tra posizioni con i piedi a distanze molto diverse per cambiare continuamente la base di supporto.
Inoltre anche a livello muscolare gli arti inferiori sono molto sollecitati (e quindi allenati) sia per il tempo in cui devono mantenere la posizione, sia in quello in cui devono muoversi. Inoltre un ruolo importante è svolto anche dal controllo del tronco che viene sottoposto a numerose rotazioni con contemporaneo mantenimento della corretta postura della parte superiore del corpo. Tutti questi meccanismi insieme sicuramente concorrono ai miglioramenti ottenuti da questi pazienti per quanto riguarda l’equilibrio e la velocità del cammino.
Un altro dato molto interessante riguarda la diminuzione del numero di cadute statisticamente significativa nei pazienti trattati con Tai Chi rispetto agli altri due gruppi. Questo dato sicuramente è una conseguenza diretta dei miglioramenti ottenuti da questi pazienti relativamente a cammino ed equilibrio.
Tuttavia un altro dato su cui gli autori di questo studio non si sono soffermati – ma che sicuramente ha una rilevanza notevole – è che il rischio di caduta, nella popolazione anziana in genere, ma soprattutto nei parkinsoniani,8Invernizzi M, Carda S, Viscontini GS, Cisari C. Osteoporosis in Parkinson’s disease. Parkinsonism Relat Disord. 2009 Jun;15(5):339-46 è direttamente correlata con il rischio di frattura di femore da “fragilità”.9Rosen C. Primer on on the Metabolic Bone Diseases and Disorders of Mineral Metabolism, Eighth Edition 2013
Stalenhoef PA, Diederiks JMP, Knottnerus JA, Crebolder HFJM. A risk model for the prediction of recurrent falls in community-dwelling elderly: a prospective cohort study. J Clin Epidemiol 2002;55:1088–94
Dargent-Molina P, Favier F, Grandjean H, Baudoin C, Schott AM, Hausherr E, et al. Fall-related factors and risk of hip fracture: the EPIDOS prospective study. Lancet 1996;348(9021):145–9
Fink HA, Kuskowski MA, Orwoll ES, Cauley JA, Ensrud KE. Osteoporotic frac- tures in men (MrOS) study group. Association between Parkinson’s disease and low bone density and falls in older men: the osteoporotic fractures in men study. J Am Geriatr Soc 2005;53:1559–64
Taylor BC, Schreiner PJ, Stone KL, Fink HA, Cummings SR, Nevitt MC, et al. Long-term prediction of incident hip fracture risk in elderly white women: study of osteoporotic fractures. J Am Geriatr Soc 2004;52:1479–86
Kanis JA, Odén A, McCloskey EV, Johansson H, Wahl DA, Cooper C; IOF Working Group on Epidemiology and Quality of Life. A systematic review of hip fracture incidence and probability of fracture worldwide. Osteoporos Int. 2012 Sep;23(9):2239-56
Hernlund E, Svedbom A, Ivergard M, Compston J, Cooper C, Stenmark J, McCloskey EV, Jonsson B, Kanis JA. Osteoporosis in the European Union: medical management, epidemiology and economic burden. A report prepared in collaboration with the International Osteoporosis Foundation (IOF) and the European Federation of Pharmaceutical Industry Associations (EFPIA). Arch Osteoporos. 2013 Dec;8(1-2):136 Tale evento si differenzia dalle fratture traumatiche di femore perché avviene in condizioni in cui normalmente non dovrebbe verificarsi come ad esempio una caduta dalla propria altezza.

I meccanismi alla base di tale “fragilità” sono da ascriversi a modificazioni quantitativo-qualitative dell’osso e della muscolatura prossimale dell’anca in grado di mantenere la stazione eretta e prevenire appunto le cadute.Tale infausto evento infatti ha dei risvolti devastanti in termini sia di mortalità (il 20% dei pazienti fratturati di femore muore ad un anno indipendentemente dall’età), che di recupero, infatti meno della metà dei pazienti ritorna a valori di indipendenza sovrapponibili al pre-frattura.10Kanis JA, Odén A, McCloskey EV, Johansson H, Wahl DA, Cooper C; IOF Working Group on Epidemiology and Quality of Life. A systematic review of hip fracture incidence and probability of fracture worldwide. Osteoporos Int. 2012 Sep;23(9):2239-56
Inoltre i costi sia sanitari che sociali, diretti e indiretti, sono altissimi: basti pensare che in Italia ogni anno si registrano circa 100mila fratture di femore da fragilità all’anno; infine, considerando il progressivo invecchiamento della popolazione, si stima che entro il 2050 tale problematica sarà un vero cataclisma per i sistemi socio-sanitari dei paesi occidentali.11Reginster JY. Bone 2006;38:S4-S9
WHO Scientific Group. WHO Technical Report Series: 921,2003:1
Wen CP, Wai JP, Tsai MK, et al. Minimum amount of physical activity for reduced mortality and extended life expectancy: a prospective cohort study. Lancet 2011; 378:1244
In conclusione quindi ormai da anni è assodato che l’esercizio fisico, eseguito anche soltanto per pochi minuti al giorno, è capace di determinare effetti positivi su svariati aspetti della salute in soggetti di qualunque età, persino over 80 anni.12Liu T, Lao L. Tai Chi for Patients with Parkinson’s Disease. COrrespondence. New Eng J Med 2012 3 May 366;18 Partendo da questo assunto, i risultati di questo studio pongono sicuramente una pietra miliare per quanto riguarda l’utilizzo a fini terapeutici del Tai Chi.
Tuttavia, nonostante gli autori vedano e sottolineino le potenzialità per un utilizzo non solo limitato al Parkinson ma in ambito più ampio alla Neuroriabilitazione, non si sbilanciano sugli effetti terapeutici del Tai Chi e dichiarano la necessità di investigare più in dettaglio i meccanismi alla base di tali risultati, non ancora del tutto compresi.

In realtà una considerazione che nasce spontanea leggendo questo articolo e i suoi risultati, anche in un non addetto ai lavori, è come il Tai Chi esprima un qualcosa “di più” in termini di efficacia rispetto al classico esercizio fisico. Tuttavia che cosa determini questo valore aggiunto non emerge in maniera così immediata e le spiegazioni meccanicistiche fornite dagli autori, per loro stessa ammissione, sono incomplete e non esaustive.
Tuttavia a mio parere questo valore aggiunto è da ricercare nelle radici stesse di questa pratica. Infatti già l’essere stata definita tecnica psico-corporea la rende sta a significare che ne è stata intuita una natura più profonda e complessa rispetto ad una qualunque tecnica di esercizio fisico. Tuttavia per comprendere meglio questa problematica è interessante citare un commento che è stato pubblicato a seguito di questo articolo:
Tai chi is definitely more than a mere set of body movements. At the core of tai chi is a unique theory based on ancient Chinese culture about the value of moving vital energy, or qi, throughout the body. Tai chi can hardly be practiced in the absence of its cultural underpinnings.
(In definitiva il Tai Chi è molto di più di una mera serie di movimenti corporei. Alla base del Tai Chi vi è una unica teoria, basata sull’antica cultura Cinese, riguardo l’importanza di muovere l’energia vitale, altrimenti detta qi, attraverso il corpo. Difficilmente si potrà praticare il Tai Chi in assenza delle sue radici culturali.)
Quindi per comprendere, o almeno cercare in parte di farlo, questa disciplina è necessario considerare le profonde radici filosofico-culturali su cui essa poggia, pena una svalutazione di tale pratica e una conseguente riduzione della sua efficacia.
Come abbiamo già accennato esse si rifanno ad una visione dell’essere umano complessa, che attinge a più tradizioni, in cui tuttavia convivono dei principi basilari e condivisi. Tra questi vi è la visione tripartita dell’uomo come un’unità indissolubile di corpo mente e spirito, che la pratica del Tai Chi cerca appunto di armonizzare.
L’identità e il conseguente dialogo tra microcosmo umano e macrocosmo e il principio della non polarità Wu Ji (vuoto) da cui origina la suprema polarità (pieno) Tai Ji che si esprime nella realtà attraverso il ricorrersi di due momenti opposti, yin e yang.
Tuttavia si cercano tanto negli ultimi anni risposte all’interno delle filosofie orientali, ma le nostre “radici”, ovvero le filosofie occidentali sostengono concetti tanto diversi?
La risposta a questo quesito, o comunque un tentativo, nella prossima puntata.
Note
| ↑1, ↑2 | Carlo Moiraghi, Tai Ji Quan, la forma breve e la forma lunga, Edizioni XX |
|---|---|
| ↑3 | Leung RW, McKeough ZJ, Alison JA. Tai Chi as a form of exercise training in people with chronic obstructive pulmonary disease. Expert Rev Respir Med. 2013 Dec;7(6):587-92 |
| ↑4 | NCCAM, National Center for Complementary and Alternative Medicine World Health Organization 2000: General guidelines for methodologies on research and evaluation of traditional medicine, Geneva, WHO, 2000. |
| ↑5, ↑7 | Li F, Fisher KJ, Harmer P, Irbe D, Tearse RG, Weimer C. Tai Chi and self-rated quality of sleep and daytime sleepiness in older adults: a randomized controlled trial. J Am Geriatr Soc 2004;52:892-900 |
| ↑6 | Li F, Harmer P, Glasgow R, et al. Translation of an effective Tai Chi inter- vention into a community-based falls- prevention program. Am J Public Health 2008;98:1195-8 |
| ↑8 | Invernizzi M, Carda S, Viscontini GS, Cisari C. Osteoporosis in Parkinson’s disease. Parkinsonism Relat Disord. 2009 Jun;15(5):339-46 |
| ↑9 | Rosen C. Primer on on the Metabolic Bone Diseases and Disorders of Mineral Metabolism, Eighth Edition 2013 Stalenhoef PA, Diederiks JMP, Knottnerus JA, Crebolder HFJM. A risk model for the prediction of recurrent falls in community-dwelling elderly: a prospective cohort study. J Clin Epidemiol 2002;55:1088–94 Dargent-Molina P, Favier F, Grandjean H, Baudoin C, Schott AM, Hausherr E, et al. Fall-related factors and risk of hip fracture: the EPIDOS prospective study. Lancet 1996;348(9021):145–9 Fink HA, Kuskowski MA, Orwoll ES, Cauley JA, Ensrud KE. Osteoporotic frac- tures in men (MrOS) study group. Association between Parkinson’s disease and low bone density and falls in older men: the osteoporotic fractures in men study. J Am Geriatr Soc 2005;53:1559–64 Taylor BC, Schreiner PJ, Stone KL, Fink HA, Cummings SR, Nevitt MC, et al. Long-term prediction of incident hip fracture risk in elderly white women: study of osteoporotic fractures. J Am Geriatr Soc 2004;52:1479–86 Kanis JA, Odén A, McCloskey EV, Johansson H, Wahl DA, Cooper C; IOF Working Group on Epidemiology and Quality of Life. A systematic review of hip fracture incidence and probability of fracture worldwide. Osteoporos Int. 2012 Sep;23(9):2239-56 Hernlund E, Svedbom A, Ivergard M, Compston J, Cooper C, Stenmark J, McCloskey EV, Jonsson B, Kanis JA. Osteoporosis in the European Union: medical management, epidemiology and economic burden. A report prepared in collaboration with the International Osteoporosis Foundation (IOF) and the European Federation of Pharmaceutical Industry Associations (EFPIA). Arch Osteoporos. 2013 Dec;8(1-2):136 |
| ↑10 | Kanis JA, Odén A, McCloskey EV, Johansson H, Wahl DA, Cooper C; IOF Working Group on Epidemiology and Quality of Life. A systematic review of hip fracture incidence and probability of fracture worldwide. Osteoporos Int. 2012 Sep;23(9):2239-56 |
| ↑11 | Reginster JY. Bone 2006;38:S4-S9 WHO Scientific Group. WHO Technical Report Series: 921,2003:1 Wen CP, Wai JP, Tsai MK, et al. Minimum amount of physical activity for reduced mortality and extended life expectancy: a prospective cohort study. Lancet 2011; 378:1244 |
| ↑12 | Liu T, Lao L. Tai Chi for Patients with Parkinson’s Disease. COrrespondence. New Eng J Med 2012 3 May 366;18 |